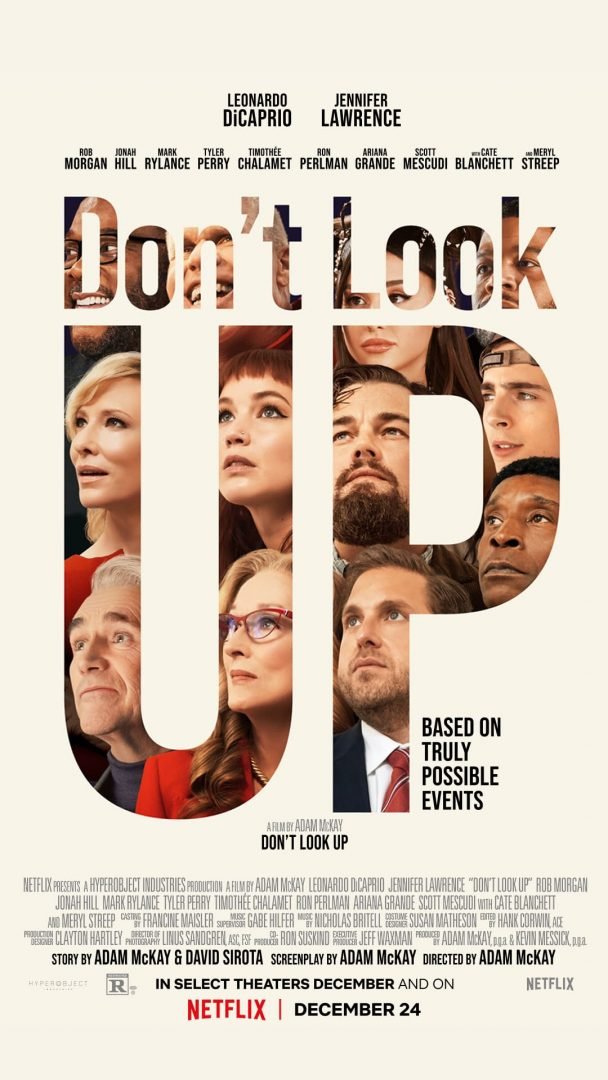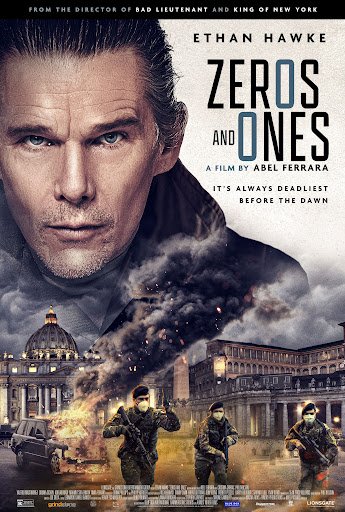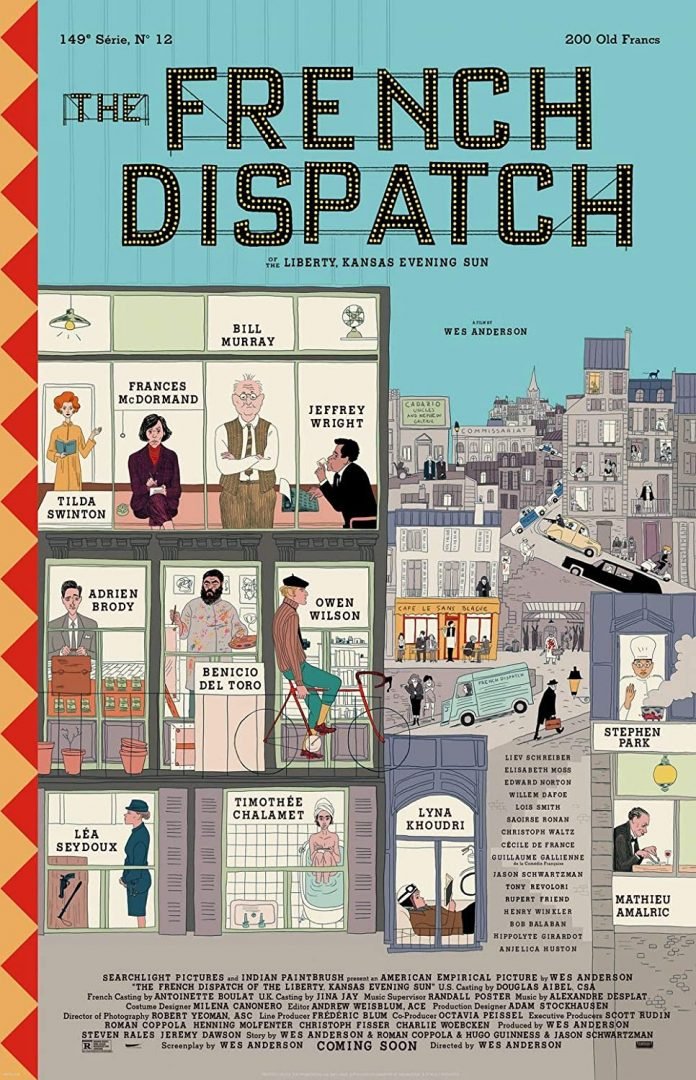Dopo un anno di pausa torniamo con l’abituale classifica dei migliori e dei peggiori film dell’anno.
Indice:
TOP 10
- È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino
- The Card Counter, Paul Schrader
- Madres Paralelas, Pedro Almodóvar
- Marx può aspettare, Marco Bellocchio
- Rifkin’s Festival, Woody Allen
- House of Gucci, Ridley Scott
- Don’t Look Up, Adam McKay
- Cry Macho, Clint Eastwood
- Old, M. Night Shyamalan
- Malignant, James Wan
FLOP 10
- Matrix Resurrections, Lana Wachowski
- Titane, Julia Ducournau
- Zeros and Ones, Abel Ferrara
- The French Dispatch, Wes Anderson
- Annette, Leos Carax
- Spencer, Pablo Larraín
- Prisoners of the Ghostland, Sion Sono
- Songbird, Adam Mason
- Zack Snyder’s Justice League, Zack Snyder
- Demonic, Neill Blomkamp
RECENSIONI BREVI DEI FILM
Sorrentino torna al cinema dopo il travagliato dittico su Silvio Berlusconi, questa volta con una produzione Netflix.
È stata la mano di Dio è, sena alcun dubbio, il suo miglior film insieme a Il Divo.
Dopo aver parlato di Loro, Sorrentino torna nella sua città natale per parlare di sé stesso, raccontando, attraverso Fabietto, suo alter ego, la propria storia, dall’adolescenza all’approdo al cinema.
Il regista firma il suo film più sentito e più personale. Liberatosi da estetizzazioni e virtuosismi stilistici, Sorrentino si concentra sui personaggi, sulle emozioni e su sé stesso, rendendo omaggio a Napoli, la città in cui è nato e cresciuto, ma soprattutto affrontando i suoi traumi in modo incredibilmente diretto e lucido.
Il regista ci racconta la sua adolescenza, intrecciando realtà e finzione in quello che possiamo considerare il suo Amarcord, laddove La Grande Bellezza faceva chiaramente riferimento a La Dolce Vita. Non a caso Fellini è presente nel film, così come altri grandi registi che hanno influenzato Sorrentino, da Sergio Leone a Antonio Capuano.
La grandezza di È stata la mano di Dio sta però nella capacità di partire dal personale e farsi universale. Come i grandi romanzi e film di formazione, i grandi coming of age, È stata la mano di Dio riesce ad essere allo stesso tempo un film personale, intimo e un’opera che parla a tutti perché chiunque ci si può rispecchiare.
Non a caso è uno dei film più accessibili del regista, uno dei più diretti. È stata la mano di Dio è il perfetto esempio d’incontro tra cinema d’autore e cinema popolare, per il grande pubblico, un connubio raro e prezioso, che poche volte ha raggiunto delle vette così elevate.
Ci sono registi che continuano a rifare lo stesso film per tutta loro carriera. Paul Schrader è uno di questi. Tra un’opera e l’altra, ritorna ai temi a lui più cari e soprattutto ai personaggi a cui si sente più vicino: degli antieroi, dannati, distrutti dai sensi di colpa, che girano in auto di notte, scrivono dei diari e forse hanno la possibilità di redimersi.
The Card counter è l’ultimo di una lunga serie di film che ripropongono le stesse tematiche e gli stessi elementi, declinandoli in modi diversi di volta in volta, raggiungendo l’apice con lo stupendo First Reformed, il vero capolavoro di Schrader, massima espressione del racconto che porta avanti da decenni.
Schrader, attraverso il suo nuovo antieroe, parla dell’America post 2001 e in particolare della ferita, mai chiusa del tutto, del campo di prigionia di Abu Ghraib.
Come First Reformed, anche The card counter è un film sul presente, sull’America di oggi, nonostante la classicità e le atmosfere che riportano all’epoca d’oro del cinema americano, la Nuova Hollywood (per cui, parlare di classicità potrebbe sembrare un paradosso).
Ancora una volta, centrale, è il tema della redenzione (impossibile) ed è commovente vedere come, nonostante siano passati dei decenni, Schrader arrivi sempre alla stessa conclusione, che ormai ci si aspetta ma che non per questa è meno sentita e dolorosa.
Arrivati al terzo posto, si può notare come il podio di questa classifica del 2021 sia occupato da film di tre nazionalità diverse. Un film italiano, uno americano e uno spagnolo. In tutti i tre casi, l’identità culturale è centrale. Si tratta di opere fortemente legate ai paesi che le hanno prodotte e alle rispettive cinematografie.
Almodovar, senza alcun dubbio, è il volto più noto del cinema spagnolo da almeno tre decenni e con Madres Parallelas torna a parlare del passato della Spagna e, come nel caso di Schrader con The Card Counter, della più grande ferita, mai rimarginata, del suo paese: il periodo del franchismo.
Madres Parallelas è un film di madri e di figli, di legami famigliari che coinvolgono molte generazioni, intrecciandosi con la storia della Spagna. È inoltre un film sulla ricerca della propria identità: identità sessuale, identità individuale ma anche collettiva.
La storia delle due protagoniste, tra le rispettive (e intrecciate) maternità e la storia d’amore impossibile, si sviluppa in parallelo a una ricerca archeologica dei corpi mai rinvenuti di chi si è opposto al regime fascista.
Ed è solo scrivendo l’ultimo capitolo della Storia passata della Spagna, che le due protagoniste possono trovare un nuovo equilibrio, formando una famiglia lontana da ogni canone e tradizione, una nuova forma di famiglia allargata che riporta alla mente lo splendido finale di Ema di Larràin.
Torniamo al cinema italiano con un’opera monumentale che non si poteva tralasciare, nonostante si tratti di un documentario. Bellocchio è uno dei più grandi registi italiani di tutti i tempi e negli ultimi anni ci ha regalato alcune delle vette della sua carriera pluridecennale.
Dopo lo stupendo Il Traditore, incentrato sulla storia di Tommaso Buscetta e sul maxiprocesso a Cosa Nostra, il regista si ripiega su sé stesso, girando un documentario che racconta la storia della sua famiglia, e in particolare quella di un suo fratello gemello Camillo, che si è tolto la vita a 29 anni nel 1968.
Come nel caso di Sorrentino, anche in questo caso il regista cerca di affrontare, attraverso il cinema, un trauma personale e intimo, in un modo però molto diverso. La scelta è quella del documentario, l’approccio è estremamente realistico e analitico, a tratti potrebbe addirittura sembrare freddo (in realtà è tutto il contrario).
Bellocchio cerca di indagare la fragile psicologia di suo fratello, i motivi che lo hanno portato a compiere quell’atto estremo e non cerca di giustificare i propri errori, mettendo in chiaro quali possano essere state le proprie colpe e mancanze.
Marx può aspettare ci racconta molto di Bellocchio e ci racconta molto del suo cinema, infatti sono presenti degli spezzoni di vari dei suoi film (I pugni in tasca, ovviamente, Gli occhi, la bocca, L’ora di religione) dai quali appare evidente quanto la morte di suo fratello abbia influenzato le sue opere, come sia stata sempre presente, in forma più o meno esplicita.
Marx può aspettare ha l’aria di una confessione da parte di Bellocchio, nata dall’esigenza di accettare ed elaborare definitivamente un lutto, da sempre raccontato attraverso il suo cinema ma mai in modo così diretto.
Come nel caso di Sorrentino, inoltre, il personale si fa universale, come sempre accade nelle grandi opere.
A proposito di registi che fanno da anni lo stesso film, oltre a Schrader, in questa categoria rientra senza dubbio anche Woody Allen che, raggiunti gli 86 anni, continua la sua attività nel mondo del cinema al ritmo di un film all’anno.
Rifkin’s Festival è esattamente ciò che ci si aspetta da un film di Allen. E non è un male, anzi.
Negli ultimi 10 anni Allen non ha (quasi) sbagliato un film, ci sono opere particolarmente riuscite, altre meno ma, con l’eccezione di To Rome with love, nessuna che non sia degna di attenzione.
Rifkin’s Festival, fortunatamente, è tra i migliori dei suoi ultimi film, un’opera attraverso la quale il regista dichiara il suo amore verso la settima arte come, forse, non aveva mai fatto prima.
Un gioiello girato da un grande cinefilo, prima ancora che regista, che cerca di omaggiare il cinema che lo ha cresciuto.
Non si tratta però di un’opera fine a sé stessa, di un semplice esercizio citazionistico e metacinematografico. Allen porta avanti le sue amare e mai concilianti riflessioni sulla vita di coppia e sulla vita in senso lato, affidandole al suo ennesimo alter ego, interpretato da Wallace Shawn e senza mai perdere il suo inconfondibile senso dell’umorismo.
A quattro anni dai suoi ultimi due film, Alien: Covenant e Tutti i soldi del mondo, Ridley Scott, alla veneranda età di 84 anni, torna con due nuove opere: The Last Duel e House of Gucci.
Nonostante entrambi siano molto riusciti, tra i migliori dello Scott post 2000, ho scelto di inserire House of Gucci perché, secondo me, è il più interessante dei due, nonché quello che attirerà più critiche negative.
House of Gucci in effetti è un oggetto particolare, meno immediato di The Last Duel, film che ha lo scopo di presentare una tesi in modo fin troppo evidente e smaccato.
House of Gucci invece ricorda certe opere del Verhoeven Hollywoodiano, è una farsa celata sotto alla confezione del blockbuster. Il concetto fondamentale, come già sottolineato da qualcuno, è quello di contraffazione, di falso. Falso come le borse Gucci dei venditori ambulanti. In questo caso si tratta di una copia di un modello tipicamente hollywoodiano: il gangster movie.
Sono chiari fin dal principio i punti di riferimenti di Scott, che per altro ha dato il suo contributo al genere con film come American Gangster.
Scott guarda ai classici del genere. E ancora una volta, come per Schrader, è paradossale il fatto che i classici in questione, siano tutti riconducibili a quei registi che hanno sconvolto la Hollywood classica, cambiando l’industria cinematografica più florida del mondo.
I titoli impossibili da non nominare sono, ovviamente, Il padrino, Scarface e tutto il contributo dato da Scorsese al genere.
House of Gucci riprende l’idea dell’epopea familiare dai film di Coppola, il fascino per quel mondo edonistico e luccicante le cui porte vengono aperte dai soldi da Scarface, l’ironia e il ritmo dei film Scorsese.
I modelli vengono rielaborati, clonati, esasperati fino a ottenere quella che si può considerare una presa in giro, quasi una parodia del genere.
Non è nuova l’operazione di applicare la struttura del gangster movie a storie di personaggi che con la mafia hanno poco a che fare, si pensi al capolavoro irraggiungibile di Scorsese, The Wolf of Wall Street.
È inedita però questa operazione, assolutamente postmoderna, di clonazione e contraffazione dei modelli.
Contraffazione perché tutto è dichiaratamente finto, non c’è per un secondo l’intento di realizzare un biopic che sia credibile e aderente alla realtà. Tutto è stereotipato, macchiettistico a tal punto da svelare la propria origine contraffatta. Ne è l’esempio più emblematico il personaggio interpretato da Jared Leto, un esempio di overacting da manuale.
È attraverso questa operazione metatestuale che Scott rappresenta la finzione di un mondo che, dietro al luccichio, nasconde il nulla, nasconde la copia di una sceneggiatura già vista, quella di una famiglia, o presunta tale, che mette in scena un gioco al massacro, in cui nessuno la scamperà, e quella del personaggio splendidamente interpretato da Lady Gaga, ammaliato dal lusso, dai soldi, l’ennesima vittima di un sogno anch’esso clonato e venduto come le borse contraffatte.
Adam McKay torna al cinema a 3 anni da Vice con Don’t Look Up, film con un cast stellare con in testa Leonardo DiCaprio.
Il regista è notoriamente interessato alla politica e i suoi film non ne fanno mai mister. È altrettanto chiara la sua posizione, che traspare perfettamente dalle sue opere, anche senza andare ad informarsi sul suo conto.
Con ancor più certezza si può dire che lo star system hollywoodiano, specie negli ultimi anni, è a prevalenza democratica, lo si capisce, ad esempio, dalle cerimonie degli Oscar, in cui si cerca sempre di affrontare tematiche sociali con un approccio che è senza dubbio indirizzato verso la sinistra progressista statunitense.
Questo impegno politico, molte volte di facciata e superficiale, si riflette in film estremamente retorici (sia quando la tendenza prevalente è quella repubblicata, come negli anni ’80 reaganiani, che quando è democratica).
McKay però scongiura questo rischio con un film affilato come una lama, che non fa distinzioni in base agli schieramenti politici, ma invece se la prende con tutti in egual misura.
Il meteorite che sta per schiantarsi contro alla Terra è chiaramente metafora del cambiamento climatico, non a caso ogni tanto compaiono riprese naturalistiche di animali, paesaggi naturali e via dicendo.
Però, probabilmente senza farlo apposta, il meteorite è anche il Covid ed è impossibile non ridere amaramente di fronte a un’analisi così spietata dei nostri tempi, che prende come bersaglio tutto e tutti: dalla politica ai media, passando per i complottisti, il mondo dello spettacolo e chiunque altro.
La comicità grottesca e surreale di un mondo che non prende seriamente la propria fine è ciò a cui abbiamo assistito in prima persona negli ultimi due anni e forse, se questo film fosse uscito prima, sarebbe risultato eccessivamente assurdo e demenziale.
Visto nel 2021 invece è innegabile che si tratti di uno dei film che meglio riescono a parlare del presente e a riflettere il periodo storico che stiamo vivendo.
Questo è la grande commedia, con un’anima nera e estremamente pessimistica che emerge tra una battuta e l’altra.
Passiamo dagli 84 anni di Scott ai 91 di Clint Eastwood, un uomo che è la storia del cinema, indipendentemente dalla riuscita o meno dei singoli film. Eastwood, tra gli alti e i bassi, tra i capolavori e i film meno riusciti, è in ogni caso una voce autorevole, anzi una delle più autorevoli, sia in campo cinematografico che non.
Dopo aver girato il suo più bel film dai tempi di Gran Torino, Richard Jewell, torna con Cry Macho, un’opera che, in tutta onestà, non è tra le vette di Eastwood, un’opera che ha molte mancanze ma che in ogni caso non si può evitare di apprezzare.
Il regista torna al neo-western, con il racconto di un ex cowboy, ormai anziano, che ha abbandonato il mito del macho, dell’uomo che non deve chiedere mai, che ha fatto i conti con le sconfitte impartite dalla vita e che sta giungendo al termine, appunto, della sua vita.
Il film è molto semplice, senza troppi fronzoli e sicuramente non resterà tra i più memorabili del regista.
Resta però il fatto che Eastwood, a 91 anni, è uno spettacolo, è un volto che, come già detto, rappresenta la storia del cinema, che è anzi l’essenza del cinema.
Inoltre Cry Macho, ha tutta l’aria di essere il canto del cigno del cinema del regista e del personaggio cinematografico che è stato costruito attorno a Eastwood nel corso degli anni, sperando che, nonostante ciò, ci possa regalare ancora tanti altri film.
Continua la seconda giovinezza di Shyamalan, regista che si era perso dopo il suo miglior film, The Village, inanellando una serie di insuccessi ad alto budget, fino al ritorno, nel 2015, grazie alla Blumhouse, a produzioni più piccole e a una maggiore libertà creativa, con The Visit.
Da quel momento si è ripreso alla grande e Old non fa eccezione, segnando anzi quello che forse è il miglior capitolo di questa terza stagione della sua filmografia.
Senza dubbio è il più estremo, quello più divisivo e infatti ha provocato reazioni agli antipodi, tra chi ha gridato al capolavoro e chi lo ha profondamente detestato.
Probabilmente la realtà sta nel mezzo, la cosa sicura è che raramente abbiamo visto Shyamalan così a briglia sciolta, sia dal punto di vista estetico che da quello narrativo.
La premessa assurda, fantascientifica, dà l’occasione al regista di concentrare in 90 minuti molte tematiche, dalla crescita, alla vecchia, alla morte, sempre con il tono grottesco che caratterizza le sue opere.
Shyamalan inoltre è arrivato a un punto in cui si avvolge su sé stesso, si autocita e si auto-include nella sua opera, come è solito fare con i suoi camei hitchcockiani, questa volta però in un ruolo fondamentale che apre a interpretazioni metacinematografiche, a dire il vero fin troppo sbandierate.
L’alternarsi di generi e registri funziona molto bene, specialmente le incursioni nell’horror grottesco. L’unica nota negativa è il finale, in cui il regista si perde in spiegazioni di ciò che non era assolutamente necessario spiegare.
Lo spiegone però, seppur evitabile, non inficia la riuscita del film e soprattutto non fa perdere di vista la cosa più importante, ovvero il talento registico di Shyamalan che regala, come sempre, delle soluzioni visive estremamente riconoscibili.
Un cinema in cui le immagini contano più delle parole, più di qualsiasi altra cosa.
Sconfiniamo nella serie B, forse anzi nella serie Z. James Wan, autore fondamentale per il cinema horror degli ultimi anni, creatore di due delle saghe horror più note e più remunerative (Saw e L’evocazione), dopo essere approdato al blockbuster e al cinecomic, torna con una piccola produzione (per i suoi standard), al genere che lo ha lanciato.
Ho già parlato di Malignant sul canale quindi non mi dilungherò più di tanto.
Malignant è una scheggia impazzita nel panorama horror contemporaneo, rifugge sia la deriva del film di esorcismi post L’evocazione, sia l’horror impegnato che è tornato alla ribalta negli ultimi anni con registi come Jordan Peele, Robert Eggers, Ari Aster e via discorrendo.
Wan, qui all’apice della libertà espressiva, affonda le mani nella palude del b-movie, senza alcuna pretesa di serietà e senza nessun tentativo di “elevare” il genere.
Una volta che si accetta la natura di serie z di Malignant, ci si trova davanti a un film folle, divertente come pochi altri, che pesca a piene mani da tutto il calderone degli horror anni ’70 e ’80, mescolando riferimenti alti e bassi, tra i quali i più evidenti sono il giallo italiano, da Bava a Argento (punto di riferimento più evidente), lo slasher e quel filone di film sui gemelli siamesi, che rimanda allo splendido Le due sorelle di Brian de Palma, passando anche per l’horror nipponico e il body horror.
Un calderone di influenze, alte e basse, che è la dimostrazione di quanto Wan se ne freghi di queste categorizzazioni, che ormai hanno fatto il loro tempo e hanno rivelato la loro limitatezza.
Malignant insomma è il perfetto guilty pleasure di questo 2021 cinematografico.
A diciotto anni di distanza dalla chiusura della trilogia di Matrix, Lana Wachowski, senza la sorella, torna con il quarto capitolo della saga, Matrix Resurrections.
Le premesse per un’opera degna d’interesse c’erano, le tematiche affrontate da Matrix sono più che mai attuali e sarebbe stato interessante vedere un aggiornamento di quelle riflessioni ai nostri tempi.
Lana tuttavia, inspiegabilmente, realizza un’opera talmente sbagliata da sembrare un tentativo di autosabotare la propria creazione, di affermare a piena voce che è impossibile realizzare un sequel di Matrix.
Tra una metatestualità sterile e priva di ogni interesse e lo spiritualismo new age che ha contraddistinto la produzione post-Matrix delle due sorelle, Matrix Resurrection è un caso più unico che raro di distruzione totale di una saga e di una mitologia. Ogni elemento dei film precedenti viene ripreso e distrutto, annullato, reso ridicolo, tanto da portare a chiedersi se sia stata una cosa voluta o meno.
Con buona probabilità, purtroppo, le intenzioni erano altre e si intuisce la volontà di affrontare certe tematiche, in modo maldestro e impossibile da prendere sul serio.
Un disastro totale che rimarrà nella storia, un caso da studiare come manuale di cosa non fare in un sequel.
Per chi volesse approfondire, ho dedicato un video all’argomento.
Julia Ducournau, dopo il non eccelso, ma tutto sommato innocuo, Raw, torna dietro alla macchina da presa con un altro horror, Titane, che ha riscosso un grande successo da parte della critica, tanto da vincere la Palma d’Oro a Cannes.
Quando facevo riferimento all’approccio anarchico di Wan in Malignant, che non ha cercato a tutti i costi di “elevare” il genere horror ed entrare nei circoli d’essai, alludevo proprio a film come Titane.
Titane è un film calcolato al millimetro, furbo, nel senso peggiore del termine. Cavalca i trend del momento ed è confezionato ad arte per riscuotere successo in questo periodo storico.
I punti di riferimento di Ducournau sono espliciti, come lo erano già in Raw. I riferimenti al body horror cronenberghiano sono urlati dall’inizio alla fine, così come quelli al Ballard di Crash, da sempre grande ispirazione per Cronenberg.
I temi cari al regista canadese vengono appena accennati, ridicolizzati, trattati superficialmente, con una trentina di anni di ritardo.
In un mondo ormai completamente digitale, tornano le ossessioni per le macchine tipiche di una società industriale, in cui il ferro, il metallo erano protagonisti, come nell’imprescindibile Tetsuo di Tsukamoto.
I richiami a questo cinema della carne vengono abbandonati molto in fretta, per lasciare spazio a tematiche molto più adatte a questo periodo storico, andando a parare sulla fluidità di genere, con l’androgina protagonista che continua a subire cambiamenti fisici e identitari.
Sicuramente questa seconda anima di Titane sarebbe stata quella più interessante e che avrebbe meritato uno sviluppo dignitoso. Tuttavia si rimane sempre in superficie, nel banale.
Si nota poi, ad appesantire il tutto, la volontà di shockare, in modo artificioso, senza mai disturbare realmente e scadendo spesso nel trash involontario.
Si pensi alla grossolanità con cui viene messo in scena il rapporto della protagonista con le automobili e alla sottigliezza e l’eleganza con cui invece Cronenberg lo aveva fatto in Crash.
Tutto sembra confezionato per impressionare un certo tipo di pubblico, non abituato all’horror, visto troppo spesso come un genere minore, di serie b.
Inspiegabile la vittoria a Cannes. O meglio, facilmente comprensibile ma imperdonabile.
Abel Ferrara, regista di innumerevoli film culto, gira questo disastro durante il Covid, in una Roma spettrale e abbandonata, quasi post-apocalittica.
Ethan Hawke accetta di partecipare a questo progetto, realizzato a risparmio, con pochi mezzi e qualche idea.
Dopo i primi minuti, in cui la visione della Roma nel periodo del Covid è effettivamente suggestiva, il film degenera in un confusionario thriller paranoico, tra tentativi di riflessione sul digitale, la cui importanza è decuplicata in seguito al Covid, sulla religione e sulla distanza sociale imposta dal virus.
In mezzo alla confusione si capiscono, in parte, gli intenti di Ferrara, anche perché ai 70 minuti circa del film vengono aggiunte, in apertura e in chiusura, due video di Ethan Hawke che presenta e spiega l’opera.
Non bastano però due spunti interessanti e l’evidente esigenza espressiva di Ferrara per salvare un totale disastro come Zeros and Ones, che sarebbe meglio dimenticare, tornando indietro negli anni ai veri gioielli che il regista ci ha regalato.
Non mi è mai piaciuto Wes Anderson. Ho sempre trovato insopportabile la sua idea di estetica dominata dalla ricerca ossessiva ed esasperata della simmetria e dai colori pastello. I suoi film mi sono sempre sembrati privi di un’anima, dei grandi lavori di scenografia e fotografia, in cui ogni frame può essere estrapolato per farci un quadro, ma che nel complesso non hanno niente da dire.
The French Dispatch è l’esasperazione della concezione di cinema di Wes Anderson. La storia, o meglio le storie, perdono quasi del tutto d’interesse e si assiste a una collezione infinita di inquadrature perfette, studiate nel minimo dettaglio ma tristemente vuote, in cui regna il nulla.
Il collage di quadretti è soporifero e le quasi due ore di durata sembrano non finire mai.
Il musical di Leos Carax è un grande buco nell’acqua, un film con evidenti pretese autoriali che scade nella banalità più totale, affrontando temi complessi con superficialità.
Peggio ancora, in molti momenti si scade nel trash involontario, come nel caso di Titane. Il trash non è male di per sé ma bisogna saperlo fare e bisogna saperlo contestualizzare.
Nel film di Carax, in cui le pretese sono ben altre, non può che infastidire.
Neanche il cast di nomi importanti, su tutti un Adam Driver costantemente sopra le righe, salva il film, colpa anche dei personaggi bidimensionali e macchiettistici che interpretano.
E infine il flop è arrivato anche per Pablo Larraín, regista tra i più interessanti tra quelli emersi nell’ultimo decennio.
Dopo il successo della parentesi hollywoodiana con lo splendido Jackie e dopo al ritorno in Cile con l’ancor più bello Ema, forse l’apice di Larraín, il regista torna con un film in lingua inglese, un altro biopic incentrato, questa volta, sulla storia di Lady Diana.
Tutto ciò che in Jackie funzionava, qui non funziona. La lista, purtroppo, è lunga.
Il maldestro tentativo di trasformare un biopic in un horror, con svariati richiami a Shining e all’horror gotico, fallisce miseramente.
Il disagio provato da Lady Diana risulta quasi ridicolo, a causa soprattutto della caratterizzazione pressoché nulla dei personaggi comprimari, dei mostri che popolano la famiglia regale.
Come può un horror funzionare se non si ha motivo per temere i mostri? L’ammiccamento all’horror resta un esercizio di stile cinefilo che stanca dopo pochi minuti.
La scelta della pellicola poi risulta completamente sbagliata, laddove in Jackie era uno degli aspetti più interessanti. La causa forse è di una color correction scriteriata, all’insegna della patinatura e dell’appiattimento dei contrasti, con il risultato di una fastidiosa patina bianca anche nelle scene più scure.
Immancabili poi i metaforoni. Ogni cosa in Spencer è un metaforone, nelle intenzioni profondo, nella pratica banale ed esibito in modo così evidente da infastidire.
Infine, insostenibile la performance di Kristen Stewart che carica oltre il limite ogni smorfia, ogni espressione, ogni battuta.
A dare il colpo di grazia ci pensa il finale al fast food, per chiudere la catena delle grandi metafore.
Ho voluto mettere nelle posizioni più elevate della flop 10 i film di nomi importanti, le delusioni più grandi di quest’anno. C’è poi la categoria dei film brutti che non hanno la pretesa di essere altro e che nascono con l’idea di essere brutti. Inserire film di questo tipo in una flop è come sparare sulla croce rossa, ci sono però delle eccezioni e una di queste è Cosmic Sin.
È chiaro ormai che Bruce Willis, che non è mai stato un grande attore ma che, nelle parti giuste, faceva il suo, abbia deciso di intraprendere un percorso vicino a quello di Nicolas Cage, accettando qualsiasi ruolo gli venga proposto.
Cosmic Sin è un film di fantascienza semplicemente orribile. Non c’è molto da aggiungere, vedere per credere.
C’è di buono che non mancano dei momenti talmente brutti da fare il giro e strappare qualche risata.
Un film sbagliato da ogni punto di vista, che potrebbe tranquillamente far parte della produzione dell’Asylum e che invece, probabilmente, non è neanche costato poco, fosse solo per la presenza di Willis e Frank Grillo.
Che peccato vedere sprecato in questo modo un potenziale cult. Sion Sono alla regia, Nicolas Cage come protagonista, un film in cui l’horror incontra l’azione, il western e il filone post apocalittico. Un Mad Max a metà tra il cinema americano e quello giapponese.
Poteva essere tutto ciò e invece è un delirante passo falso per uno dei più grandi registi giapponesi degli ultimi anni che, inspiegabilmente, ha accettato di partecipare a questo progetto.
Non funziona né come film di puro intrattenimento, né come opera di Sono.
Un passo falso che lascia l’amaro in bocca per l’occasione sprecata.
a pochi mesi di distanza dalla comparsa del Covid-19, a ottobre del 2020, è uscito su Youtube il trailer di Songbird e la domanda che tutti si sono posti è stata: come è possibile che abbiano girato un film sul Covid in così poco tempo?
Songbird è il vero mistero di questo 2021. Un’operazione di sciacallaggio, prodotta da Michael Bay, che aveva tutte le carte in regola per fare successo.
I riferimenti al Covid sono espliciti: si parla di un mondo post-apocalittico, devastato dal Covid-23, in cui i governi hanno preso una deriva autoritaria alla 1984.
Insomma, un film che poteva offrire spunti interessanti o che poteva essere brutto ma fare leva sugli istinti complottistici di parte del pubblico e quindi restare sotto ai riflettori per molto tempo.
Ovviamente è un film molto brutto, con poche idee e fondamentalmente ci si dimentica di averlo visto dopo poco tempo.
La cosa curiosa tuttavia è come sia scomparso dalla circolazione senza fare rumore. Il trailer aveva riscosso un discreto successo su Youtube, con circa 6 milioni di views, ma il boxoffice parla chiaro: Songbird non lo ha visto nessuno. È caduto nel dimenticatoio e ha incassato molto meno di quanto è costato.
Un’operazione di sciacallaggio fallita miseramente dunque, sarebbe interessante indagare il perché.
in seguito alle lotte intraprese dai suoi fan sui social network, Snyder è riuscito a ottenere la possibilità di lavorare alla director’s cut di quel disastro che è stato Justice League.
C’è da dire che questo film passerà alla storia per la travagliata vicenda produttiva che meriterebbe un video a parte. Sono ancora molti gli interrogativi rimasti aperti, come ad esempio la campagna di marketing sospettosamente sottotono da parte di Warner Bros e DC Films, ma ciò che importa è che alla fine Snyder sia riuscito a presentarci la versione di Justice League di cui ci ha tanto parlato.
E il risultato, manco a dirlo, è deludente. Dispiace dare contro a questo film, perché si percepisce l’intento di Snyder di parlare, attraverso il cinema, del lutto che ha subito, la morte di sua figlia.
Si intuisce quindi un’esigenza espressiva che non si può evitare di apprezzare ed è per questo che Zack Snyder’s Justice League si posiziona in fondo alla flop 10.
Tuttavia, i 242 minuti della director’s cut sono difficili, se non impossibili, da reggere. Un tripudio di tutto ciò che ha reso Snyder così odiato e amato allo stesso tempo.
Slow-motion in ogni scena, post produzione così spinta che riesce a far sembrare tutto finto nonostante il film sia girato in pellicola, tono solenne e serioso classico dei film superoistici di Snyder, qui all’apice del proprio egocentrismo e della sua indole artistoide, con la scelta dei 4:3 come esempio emblematico.
Il film si prende troppo sul serio, senza poterselo permettere, e dispiace dirlo perché Snyder, quando vola più basso, gira anche film accettabili, come ad esempio Army of the Dead, uscito anche questo nel 2021.
Blomkamp, regista sudafricano che aveva debuttato con il magnifico District 9 e che aveva continuato a gonfie vele, portando la sua idea di fantascienza sporca e fortemente politicizzata ad Hollywood, torna dietro alla macchina da presa dopo 6 anni di pausa e innumerevoli problemi con le case produttrici americane.
Inutile girarci intorno, l’incursione di Blomkamp nell’horror demoniaco (unito alla fantascienza) è un fallimento. Il film è molto brutto, nonostante ciò ho deciso di metterlo all’ultima posizione della flop 10, ovvero quella meno grave, per i seguenti motivi.
Demonic, come Zeros and ones è stato girato da Blomkamp durante il periodo del Covid-19, perché il regista non voleva restare con le mani in mano e perché voleva sperimentare una nuova tecnologia chiamata volumetric capture.
Blomkamp cercava insomma un modo per sperimentare questa tecnologia, che è attualmente ancora in una fase seminale, e ha costruito il film attorno alle poche sequenze oniriche realizzate appunto tramite volumetric capture.
È in questo senso un film sperimentale, realizzato dal regista in un periodo di fermo, come quello del Covid-19, con il principale intento di prepararsi a usare questa tecnologia in futuro.
Visto in quest’ottica, si può giustificare il passo falso del regista, che resta comunque un pessimo film e che sembra girato con la mano sinistra a occhi chiusi.
Scritto da: Tomàs Daniel Avila Visintin
Qui potete vedere la versione video di questa top e flop 10 del 2021: